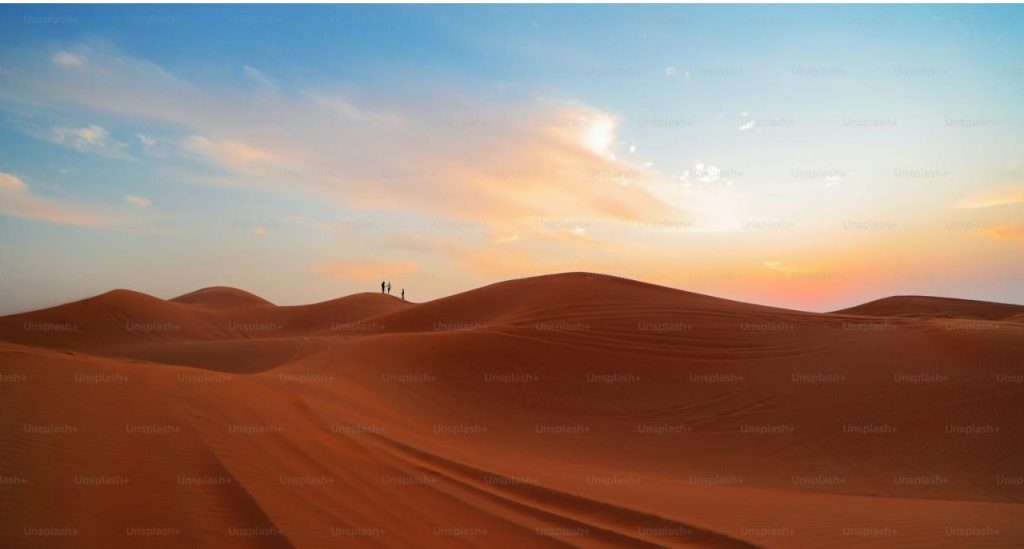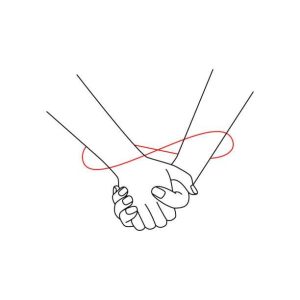GUERRA E PACE
L’euforia attraversa le latitudini e le longitudini del pianeta. L’accordo di pace concepito dall’amministrazione Trump ha avuto successo, almeno per ora, e l’agognato ritorno a casa degli ostaggi israeliani è avvenuto, mentre rimane ancora incerta la restituzione dei corpi dei non sopravvissuti alla barbarie del rapimento e della reclusione. Alla soddisfazione della politica mondiale e a quella di molta gente comune si unisce la gioia del popolo di Gaza, esultante per la notizia e per gli effetti immediati dell’accordo: il ritiro parziale delle unità delle IDF dal territorio occupato, la sospensione delle azioni militari e lo scambio degli ostaggi israeliani con centinaia di prigionieri palestinesi. La morsa stretta sui Ghazawi dopo il 7 ottobre 2023, rilascia dunque la pressione mortale dei bombardamenti aerei e di artiglieria, con essi della distruzione e delle macerie, della denutrizione, della privazione degli essenziali mezzi di sostentamento e dell’assenza di basilari cure sanitarie a danno della popolazione palestinese. Si accende la speranza, ma è una luce, va notato, adombrata dalla minaccia di un ritorno alla forza delle armi se qualcosa dovesse andare storto, cioè se l’accordo fosse disatteso da Hamas che è, con evidenza, la parte soccombente. La minaccia giunge dai più forti, cioè da coloro che hanno scritto i punti del trattato dopo aver messo “a ferro e fuoco” Gaza. È evidente che si tratta, secondo il lessico della diplomazia bellica, di una vittoria di una parte e di una resa dell’altra. In qualche modo, ci sovviene di credere, è la conclusione di una guerra, se è vero, come abbiamo ripetutamente sentito dire, che di guerra si è trattato.
Una guerra, tuttavia, ha la prerogativa di contrapporre sul campo le forze armate delle due (o più) parti. Ciò accade secondo criteri di simmetria degli sforzi esercitati dai belligeranti, almeno nelle fasi iniziali dei combattimenti. E ciò non è accaduto a Gaza, non almeno nel senso convenzionale del termine che ho poc’anzi esplicitato. Neppure possono bastare decine di migliaia di morti a rispettare l’appropriatezza del lessico, soprattutto quando la maggior parte delle uccisioni non riguardi i militari, bensì la popolazione civile. In una guerra vera – cruenta, violenta, spaventosa – gli scontri armati convenzionali sono condotti su un piano di confronto sostenibile tra le parti, si incardinano sulla manovra delle forze e del fuoco sia aereo sia terrestre, si animano con la logistica che assicura i rifornimenti e le attività di sostegno allo sforzo bellico. Alla fine prevale il più forte, il più potente, il più tenace. Alla convenzione dell’uso delle armi, si affiancano le forme di confronto ibride. Agli effetti letali degli armamenti si sommano quindi i nocumenti prodotti dalla disinformazione, dalla sovversione, dal terrorismo, dalla destabilizzazione sociale, dalla sottrazione delle risorse, dagli attacchi cibernetici alle reti informatiche e ai sistemi digitali, dall’alterazione della percezione e dello spazio cognitivo dell’avversario. Lo scopo perseguito è quello d’indebolire l’opponente scardinandone la volontà di combattere o di resistere, La guerra ha termine, in fine, quando una delle parti in lotta non ha più speranza di vittoria.
Guardo a quanto accaduto a Gaza negli ultimi due anni, forse anche prima, e ne ricavo l’impressione che non si sia trattato di una guerra nel senso convenzionale del termine, e che utilizzare l’espressione “guerra” abbia ingenerato una falsa impressione su quanto accaduto. Si tratta, ritengo, di qualcosa di molto diverso e di non facilmente definibile. Cerco, dunque, un lessico più appropriato: lo faccio attingendo alle mie conoscenze militari, esplorando l’anomalia di un confronto che contrappone uno degli eserciti più potenti del mondo a un’organizzazione che fa del terrore, anche di quello esercitato nei confronti della propria stessa gente, il punto di forza. In fondo, molto altro Hamas non può fare. Lo scenario delle macerie favorisce la difesa a oltranza, l’uso della popolazione come scudo amplifica l’efficacia della resistenza, l’ambiguità di chi opera per scopi diversi, anche umanitari, nell’ambiente operativo genera confusione, e ciò va a favore di chi per colpire deve nascondersi, per poi agire proditoriamente. Dall’altra parte vi è la macchina tecnologica di uno degli eserciti più moderni e più potenti del mondo. L’intelligence è sovrana, seppur confusa dal deturpamento dell’ambiente in cui è condotta la ricerca; i sistemi d’arma sono poderosi, capaci di una potenza distruttiva mai vista e udita in precedenza; i dispositivi di sorveglianza operano a più strati, da quelli esosferici satellitari ai dispositivi tattici diurni e notturni; il controllo del territorio pone in una posizione di supremazia inscalfibile le forze israeliane, poiché di Gaza si controllano gli accessi da ogni provenienza; la popolazione è mossa da nord a sud senza tregua, assediata, affamata, privata di mezzi di sostentamento, stremata. Le scene di dolore sono bibliche e superano, nonostante la disinformazione, i confini tra gli Stati del mondo.
Non mi arrendo e continuo a pensare a un’altra definizione. “Lotta al terrorismo” potrebbe essere una soluzione; in fondo gli americani ne avevano già fatto uso coniando l’acronimo G.W.O.T. “global war on terror”. Tuttavia l’espressione presenta l’anomalia di essere più adatta, sotto il profilo etico-giuridico, a una forma di contrapposizione all’interno di uno Stato, molto meno nel rapporto tra gli Stati. È pur vero che i trent’anni trascorsi tra il 1990 e il 2020, quando l’Occidente ha ingaggiato la guerra globale al terrorismo, ci hanno abituati alle operazioni militari per la sicurezza internazionale, dove uno Stato o una coalizione tra Stati esercitava la forza militare, con varie modulazioni di potenza, per contrastare forme di terrorismo provenienti da lontano e per neutralizzare compagini statuali e non statuali aduse alla violenza ai nostri danni. Poco conta che in taluni casi quelle operazioni si siano rivelate vere creazioni artificiose, realizzate quasi in stile hollywoodiano per giustificare l’esercizio di potenza all’interno del territorio sovrano di stati terzi. I casi più emblematici sono l’Iraq, con la caduta di Saddam Hussein, e la missione in Afghanistan dopo l’attentato terroristico alle Torri Gemelle: una missione durata vent’anni e caratterizzata dall’invocazione del principio di difesa collettiva dell’Alleanza Nordatlantica, unico caso nei quasi ottant’anni di storia della NATO in cui l’articolo 5 del trattato sia stato applicato.
Guardo poi a quanto sta accadendo ancora oggi in Ucraina, teatro di una conflitto intra-statuale iniziato nel 2014 tra le milizie filorusse nella regioni orientali del Donbass e le forze armate ucraine, innescato in origine dall’annessione della Crimea a Mosca e dall’allineamento con l’Occidente del governo di Kiev, poi degenerato nel 2022 con l’attacco militare russo al cuore dell’Ucraina oltre che nelle già martoriate regioni orientali. Tecnicamente, quel conflitto è una guerra vera, articolata in tutte le forme di combattimento possibili: dalla manovra incentrata sull’impiego dei carri e dei sistemi controcarro, al logoramento statico delle trincee, agli attacchi aerei portati con moderne tecnologie missilistiche e con sciami di droni armati, per arrivare infine all’ampia gamma di profili di confronto ibrido, specie nel campo cognitivo e dell’informazione. Nonostante l’appropriatezza in questo caso del termine guerra, neppure l’aggressore Putin ne ha fatto uso in modo esplicito, preferendo definire le azioni belliche condotte in territorio ucraino come le mosse di una “operazione speciale”.
Insomma, non riesco a venirne a capo. Poco cambia. Alla fine è distruzione, morte, crimine. Il tutto in attesa di una catarsi di cui la parola “pace” ne è l’epitome lessicale. Mi rendo conto, allora, che “guerra e “pace” sono le forme antinomiche dello stato della nostra anima, inutili e impotenti per incidere su cose che sono più grandi di noi, ma delle quali abbiamo bisogno per giustificare l’ingiustificabile e per intravvedere, tra tanta miseria, una luce di speranza.
Con la speranza, in verità, che non si tratti ancora una volta di un inganno.